|
Morte a Franz, viva Oberdan!
Morte a Franz, viva Oberdan!
Le bombe, le bombe all’Orsini,
il pugnale, il pugnale alla mano
a morte l’austriaco sovrano
e noi vogliamo la libertà.
Morte a Franz, viva Oberdan!
Morte a Franz, viva Oberdan!
Vogliamo formare una lapide
di pietra garibaldina;
a morte l’austriaca gallina,
e noi vogliamo la libertà.
Morte a Franz, viva Oberdan!
Morte a Franz, viva Oberdan!
Vogliamo spezzare sotto i piedi
l’odiata austriaca catena;
a morte gli Asburgo-Lorena,
noi vogliamo la libertà.
Morte a Franz, viva Oberdan!
Morte a Franz, viva Oberdan!
Morte a Franz, viva Oberdan!
Anonimo
1882 circa
Adottato dai Repubblicani di Ancona fin dal 1882, i
personaggi citati in questo brano di autore ignoto sono
Felice Orsini e Guglielmo Oberdan. Due personaggi, due
attentatori alle tiranniche “corone” d’Europa.
Felice Orsini, nato a Meldola il 10 dicembre 1819,
figlio di un carbonaro, nel 1858 compie il suo gesto
attentando alla vita dell’Imperatore di Francia
Napoleone III. Era stato con Mazzini per tutto il
periodo della Repubblica romana e ancora dopo fino al
‘54, quando gli austriaci l’avevano arrestato in
Ungheria e rinchiuso nel castello di Mantova.
Successivamente però, con Mazzini aveva rotto. Voleva
avvicinarsi a Cavour, a cui aveva anche scritto una
lettera. Era anche conosciuto per via delle Memorie
pubblicate in Inghilterra. Nel libro rivolgeva
critiche molto aspre a Mazzini e dichiarava la sua
disponibilità a collaborare con il governo piemontese
nella eventuale guerra contro l’Austria. Conosciuto da
tutte le polizie d’Europa, gli austriaci lo avevano
catturato nel ’54, poco dopo il secondo moto della
Lunigiana e la cospirazione in Valtellina. Ma i primi a
mettergli le manette erano state le guardie pontificie
nel ’44. Poi, aveva svolto mansioni importanti nella
Repubblica romana: era stato incaricato di metter fine
agli eccidi e ai pestaggi con cui i patrioti si
vendicavano delle angherie subite dai sanfedisti. Era
stato mandato ad Ancona come commissario, quindi aveva
partecipato alla difesa di Ascoli, alla ritirata su
Spoleto, ai combattimenti della capitale. Era stato
anche con Manin nella famosa sortita di Mestre che costò
agli austriaci un centinaio di morti. E poi, nel 1856
c’era stata la fuga dal castello di Mantova, forse
la sua impresa più clamiorosa dato che pareva
impossibile scappare dal castello. Infine l’attentato a
Napoleone III, la sera del 14 gennaio 1858. Vi era
allora una corrente di pensiero, anche tra i non
mazziniani, secondo la quale il perno del sistema
reazionario nel mondo era Napoleone III. Lo pensava
anche Marx, che, quando Napoleone aveva vinto le
elezioni presidenziali, aveva detto che tornavano a
regnare in Francia sia i Borboni che gli Orléans. Orsini,
che aveva organizzato una società segreta, “I Figli
della Patria”, pensava che alla morte di Napoleone III i
popoli soggetti d’Europa si sarebbero “levati” per
“darsi l’un l’altro la mano”, per “mettere in atto ciò
che vuole la solidarietà delle nazioni”. Era convinto
che bisognasse “aspettare operando”, cioè approfittare
“delle modiche libertà del Piemonte, per ispargere nelle
vicine contrade, soggette al dispotismo, i lumi, i mezzi
della propaganda rivoluzionaria”. Intanto però credeva
anche che non sarebbe stato inutile liberarsi del
“despota… che tiene compressa con una mano di ferro
l’Europa intiera”. Ecco perciò l’idea dell’attentato.
Orsini e i suoi compagni agirono quando Napoleone e
l’imperatrice Eugenia intervennnero a una prima
dell’Opéra. Tre bombe lanciate sotto la carrozza
esplosero simultaneamente. Lo scoppio spense tutti i
lampioni a gas. Nell’oscurità, tra i nitriti dei cavalli
morenti e il panico della folla si contarono quattro
morti e 104 feriti tra la scorta e il pubblico. Quattro
feriti erano gravissimi e spirarono pochi giorni dopo.
Dunque, otto morti in tutto. L’imperatore e
l’imperatrice, con l’abito bianco insanguinato,
sortirono illesi. Il processo ad Orsini si trasformò in
un formidabile atto d’accusa all’Austria, ripreso dalla
stampa di tutta europa. Orsini, assolutamente pentito
del suo gesto, scrisse una lettera all’imperatore e il
suo avvocato, che era il grande Jules Favre, ottenne il
permesso di leggerla in aula. La lettera diceva: “Sire,
sta oggi in poter vostro di fare l’Italia indipendente o
di tenerla schiava dell’Austria e di ogni specie di
stranieri. Intendo io forse con questo che il sangue dei
francesi sia sparso per gli italiani? No: eglino non vi
domandano ciò; essi chiedono che la Francia non
intervenga contro di loro: essi chiedono che la Francia
non permetta che alcuna nazione intervenga nelle future
e forse imminenti lotte dell’Italia contro l’Austria ...
Non disprezzi la Maestà Vostra Imperiale le parole di un
patriota che sta sul limitare del patibolo: renda
l’indipendenza alla mia patria e le benedizioni di 25
milioni di abitanti la seguiranno dovunque”.
Hubner, l’ambasciatore austriaco in Francia, annotò nel
suo diario che la corte d’assise aveva “trasformato
l’assassino in un martire politico” e che il difensore
di Orsini aveva fatto “un discorso tutto politico da
capo a fondo, in favore dell’Italia libera e contro
l’Austria”. Aggiungeva poi che “l’imperatrice aveva
perduto la testa per lui, e non faceva che piangere e
invocare, per salvare la vita di questo miserabile, la
clemenza di suo marito”. Il modo in cui era stato fatto
il processo, con la lettura pubblica della lettera di
Orsini, gli sembrava uno scandalo inaudito. Orsini fu
condannato alla ghigliottina, benché Napoleone lo
volesse graziare. Sentiva adesso una simpatia fortissima
per il rivoluzionario, ma i suoi ministri glielo
impedirono con forza. Così il 13 marzo, insieme con
Pieri, salì al patibolo. Era assolutamente calmo. Gridò
“Viva la Francia! Viva l’Italia!”. Prima di morire,
aveva scritto un’altra lettera a Napoleone. Diceva: “
Fra poche ore io non sarò più: però prima di dare
l’ultimo respiro vitale, voglio che si sappia, e il
dichiaro con quella franchezza e coraggio che sino ad
oggi non ebbi mai smentiti, che l’assassinio sotto
qualunque veste e’ s’ammanti non entra ne’ miei
principi, abbenché per un fatale errore mentale io mi
sia lasciato condurre ad organizzare l’attentato del 14
gennaio. No, l’assassinio politico non fu il mio
sistema, e il combattei esponendo la mia vita stessa,
tanto cogli scritti quanto co’ fatti pubblici, allorché
una missione governativa mi poneva in grado di farlo. E
i miei compatrioti anziché riporre fidanza nel sistema
dell’assassinio, lungi da loro il rigettino, e sappiano
per voce stessa di un patriota che muore, che la
redenzione loro deve conquistarsi coll’abnegazione di
loro stessi, colla costante unità di sforzi e di
sacrifizi, e coll’esercizio della virtù verace: doti che
già germogliano nella parte giovane e attiva de’ miei
connazionali, doti che sole vorranno a fare l’Italia
libera, indipendente, e degna di quelle glorie onde i
nostri avi la illustrarono. Muoio, ma mentre che il
faccio con calma e dignità, voglio che la mia memoria
non rimanga macchiata da alcun misfatto. Quanto alle
vittime del 14 gennaio, offro il mio sangue in
sacrificio, e prego gli italiani che fatti un dì
indipendenti diano un degno compenso a tutto coloro che
ne soffrirono danno”.
Nella popolare radicalità della canzone di ignoto, che
non tiene conto delle pieghe complesse della storia,
l’accenno alla figura di Orsini assume i contorni
contraddittori di un pericoloso idealista, pronto a
commettere atti violenti pur di portare a compimento i
propri fini politici. Ciò nonostante l’impresa di Orsini,
ricordata a Imola da una lapide e da una via, fu
idealizzata in Romagna e nelle Marche come un atto di
eroismo estremo e di profondo amore patrio e la sua
condanna fu pianta come un “sacrificio” e un “martirio”,
dimenticando che la morte procurata ad un proprio simile
(soprattutto se innocente) non può mai assurgere ad atto
di valore e non tenendo conto delle ultime sue nobili e
accorate lettere.
Ma
nella canzone il vero protagonista è il Massone
Guglielmo Oberdan insieme alla questione delle terre
“irredente”, ancora sotto il giogo dell’Austria.
Guglielmo Oberdank, triestino irredentista, trascorre la
sua breve vita – era nato il 2 febbraio 1858 - lottando
per gli ideali repubblicani e libertari. Dopo gli studi
medi nella città natale, nel 1877 si trasferì a Vienna
dove iniziò gli studi di ingegneria ma, richiamato alle
armi l’anno successivo, rimandò al suo colonnello divisa
e baionetta, con le parole “Il mio sangue non è per
voi”, fuggendo a Roma dove frequentò l’università
svolgendo contemporaneamente un’intensa attività
irredentista. Dal 1879 al 1882, la santa causa
dell’irredentismo doveva attraversare giorno per giorno
un nuovo lutto ed una nuova amarezza. Sulla fine del
1879 si spegneva l’anima del partito con la morte del
generale Giuseppe Avezzana, membro del Consiglio
dell’Ordine del Grande Oriente d’Italia alla Costituente
di Roma del 1872. Ai primi del 1881, falliva un nuovo
disegno di sconfinamento in territorio austriaco a cui
dovevano partecipare Ricciotti e Menotti Garibaldi e al
quale si sussurrava prestasse il proprio consenso lo
stesso Giuseppe Garibaldi. Lo stesso Garibaldi, ‘Primo
Massone d’Italia’ e dal 1872 Gran Maestro Onorario a
vita del Grande Oriente d’Italia, nel marzo da Napoli
lanciava con la sua firma e con le sue istruzioni
numerosi proclami per un prossimo movimento, dicendo che
nell’ultima guerra che sarebbe stata combattuta contro
l’austriaco avrebbe preso parte anche lui con qualunque
mezzo. Ma il 20 maggio ogni speranza in un consenso
della Nazione ad una qualsiasi riscossa contro
l’Austria, falliva. In quel giorno l’Italia firmava il
primo trattato della Triplice Alleanza. Tredici giorni
dopo questo avvenimento, Giuseppe Garibaldi, il creatore
di Eroi, l’immortale vincitore di cento battaglie, la
grande gloria d’Italia, si spegneva nella sua romita e
prediletta isola di Caprera, e la fulminea morte di lui,
suscitò anche nelle anime più giovani tutto il fascino e
la santa poesia dell’entusiasmo per l’epopea
garibaldina. La scomparsa di Giuseppe Garibaldi, non
solo doveva segnare la fine di ogni tentativo
irredentista a mano armata, ma altresì il principio di
una nuova era di persecuzioni per gli Italiani soggetti
disgraziatamente all’Austria. A Roma, l’11 giugno furono
celebrati solenni funerali, e l’onore di portare la
bandiera di Trieste, toccò ad Oberdan, e quando il
corteo passò davanti a piazza Colonna, egli alzò il
capo. Sui balconi del Palazzo Fiano erano l’ambasciatore
austriaco ed il personale dell’Ambasciata. Guglielmo
emise un grido, che nel silenzio parve un ruggito, e
levando in alto la bandiera, la scosse vigorosamente
come per una sfida ed una minaccia. I balconi
dell’Ambasciata, in un batter d’occhio rimasero deserti.
Guglielmo Oberdan ed i suoi amici vivevano ancora in
quella calda atmosfera, dove si pensava che solo un
richiamo, un grido, un esempio, potessero bastare a
suscitare milioni di petti; là dove si era
indubitatamente certi che il sangue versato dovesse
necessariamente fruttificare nel presente o
nell’avvenire. Non vi era dunque bisogno di un piano
positivo e determinato; l’importante era: incominciare
ad agire! Oberdan infatti, si era in quelle ultime
settimane affaccendato ad accordarsi cogli amici
repubblicani e irredentisti d’Italia; aveva corrisposto
cogli amici di Trieste per una insurrezione popolare, ma
partiva senza nulla avere definito nel suo pensiero,
salvo questo: “di agire, anzi di reagire; il come e il
quando, sarebbero dipesi dalle circostanze”. Nel
settembre del 1882, in occasione di una visita che
l’imperatore Francesco Giuseppe si accingeva a compiere
a Trieste, per il quinto centenario della così detta
“dedizione” della città agli Asburgo, Oberdan partì per
la città natale, insieme all’istriano Donato Ragosa, con
l’intenzione di compiere un attentato contro di lui.
Vuole attirare l’attenzione dell’Europa sulla questione
Italiana con un gesto eclatante e al contempo stesso
diretto contro uno dei massimi oppositori delle idee
libertarie. Prima però scrisse, in caso di catastrofe,
un bellissimo testamento politico:
Ai fratelli italiani,
Vado a compiere un atto solenne e importante.
Solenne, perché mi dispongo al sacrificio; importante, perché darà i
suoi frutti.
È necessario che atti simili scuotano dal vergognoso torpore l’animo dei
giovani – liberi e non liberi –.
Già da troppo tempo tacciano i sentimenti generosi, già da troppo tempo
si china vilmente la fronte ad ogni specie d’insulto
straniero. I figli dimenticano i padri il nome italiano
minaccia di diventar sinonimo di vile o d’indifferente.
No, non possono morire così gl’istinti generosi!
Sono assopiti, e si ridesteranno.
Al primo allarme correranno i giovani d’Italia – correranno coi nomi dei
nostri Grandi sul labbro – a cacciare per sempre da
Trieste e da Trento l’odiato straniero che da tanto
tempo ci minaccia e ci opprime. Oh, potesse questo mio
atto condurre l’Italia a guerra contro il nemico! Alla
guerra, sola salvezza, solo argine che possa arrestare
il disfacimento morale, sempre crescente della gioventù
nostra.
Alla guerra, giovani, finché siamo ancora in tempo di cancellare la
vergogna della presente generazione, combattendo da
leoni.
Fuori lo straniero: E vincitori e forti ancora del
grande amore della patria vera, ci accingeremo a
combattere altre battaglie, a vincere per la vera idea,
per quella che ha spinto mai sempre gli animi forti alle
cruenti iniziative, per l’idea repubblicana.
Prima indipendenti, poi liberi.
Fratelli d’Italia! Vendicate Trieste e vendicatevi!
Settembre 1882.
Tradito da una spia e trovato in possesso di due bombe
“all’Orsini”, fu arrestato. Tre interminabili mesi durò
la sua prigionia; tre mesi di strazi e di ansie dovette
vivere, ora per ora, nel fondo d un carcere. Rinchiuso
nella sua segreta, fu morto per il mondo; non vide più
nessuno, ed in tutto quel periodo ebbe la saldezza
sublime del martire. Condannato a morte sulla forca,
alla lettura della sentenza egli sorrise, e fissando sui
giudici i suoi occhi azzurri e sereni, con ferma e
squillante voce, gridò loro in faccia: Grazie! La madre
disperata, impetrò a Vienna, ma invano, la grazia
sovrana; e la invocò pure il nostro massimo poeta, il
Carducci. Il poeta dell’umanità Victor Hugo, cosi
telegrafava all’imperatore: “La pena di morte è abolita
per ogni uomo incivilito. La pena di morte sarà
cancellata dai codici del ventesimo secolo. Sarebbe
bello praticare fin d’ora una legge dell’avvenire.”
Dopo
che Francesco Giuseppe aveva rifiutato la grazia, il
contegno del martire durante la notte e durante i
lugubri preparativi, apparve di una tranquillità stoica.
Nel silenzio tragico il condannato con la sua voce
giovanile e serena, cantava patriottiche canzoni, mentre
la soldatesca croata, sghignazzando lo insultava. Salì
sul patibolo, esclamando con voce ferma: “ Muoio
contento, perché spero che la mia morte, gioverà a
riunire la mia cara Trieste alla madre patria.” Gli fu
imposto di tacere, si ordinò ai tamburi di coprirne col
rullo la voce. Guglielmo, a capo scoperto e con il petto
mezzo ignudo; senza opporre alcuna resistenza, porse
egli stesso le mani incrociate per farsele legare con
uno spago, e col capestro intorno al collo, volle ancora
gridare per l’ultima volta: “Viva Trieste libera! Viva
l’Italia! Viva l’It...”. Quel grido, convulsamente
lacerato dalla stretta implacabile, doveva poi
ripercuotersi nell’anima e sulle labbra di tutto un
popolo. Era il 20 dicembre 1882, aveva solo 24 anni.
Scriverà quel giorno Gosuè Carducci, membro della
Rispettabile Loggia Felsinea di Bologna: “Morto
santamente per l’italia terrore ammonimento / rimprovero
ai tiranni di fuori ai vigliacchi di dentro”. E ancora
questi versi profetici:
No. Guglielmo Oberdan non è un condannato.
Egli è un confessore ed un martire della Religione della
Patria.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
giorni migliori – e verranno, e la bandiera d’Italia
sarà piantata su ’l grande arsenale e su i colli di San
Giusto –, a giorni migliori, l’apoteosi.
Ora silenzio.
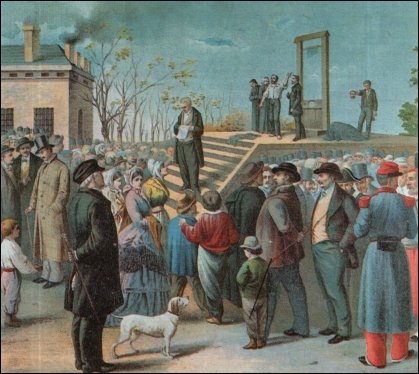
Felice
Orsini al patibolo
(Museo del Risorgimento di Roma)

Guglielmo Oberdan
|